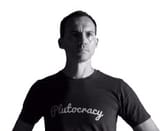INTERVISTA: L'arte videoludica di Giovanni Fredi: Kinshasa vs Akihabara (2011)
"Kinshasa vs Akihabara" e' il nuovo progetto fotografico di Giovanni Fredi (Brescia, 1984), giovane artista italiano che ha esaminato la cultura e l'ideologia dei videogame in due contesti sociali radicalmente differenti.
Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo e Akihabara, quartiere di Tokyo - Giappone e capitale mondiale dei videogame. Sale giochi improvvisate costruite con legni e ricoperte con teloni di camion, sparse tra i vicoli labirintici delle province della capitale della Repubblica Democratica del Congo. Uno scenario che ha dell’irreale tra elettricità rubata, fogne a cielo aperto e PlayStation. E poi, trecento scatti che raccontano uomini e donne con il medesimo strumento tra le mani, persi nei loro Nintendo DS in un piazzale antistante un centro commerciale ad Akihabara.Giovanni Fredi li descrive cosi:
"Otaku. Il cervello è flippato, a cinque centimetri dai display del DS, parlano da soli, cappuccio in testa sono dissociati dalla realtà/società anche quando ci si trovano in mezzo, cercano il buio intorno a se stessi sono immersi anche fisicamente nell'apparecchio. Gobba, mani mostruose dal colore rossastro. Hanno una dimensione fisica, respirano ma la loro presenza è immateriale. Buchi neri della società. Stregoni della rete. Avidi di mega bite e uniti solo dalla fame di reti wifi. Emarginati che si emarginano tramite link. Oratori silenziosi. Occupano spazio fermi immobili, ora dopo ora. Cavi che escono dai loro zaini, batterie al loro interno, a volte due tre quattro strumenti tra le due mani. (Tokyo 07/11/2010 ore 00.02)"
GameScenes: Come nasce il progetto "Kinshasa vs Akihabara"? Qual è la tua definizione di otaku, ora che hai potuto toccare con mano questa sottocultura? Ci racconti genesi ed evoluzione della tua documentazione fotografica?
Sono partito per la Repubblica Democratica del Congo a febbraio di due anni fa e l’ultima cosa che pensavo avrei trovato era una PlayStation. E’ stata una sorpresa scoprire in quei luoghi una cultura legata ai videogame, scoprire che anche in quella parte di mondo era arrivato PES2008, vedere che anche dove l’elettricità salta a ogni tuono qualcuno aveva trovato il modo di far funzionare una console con un generatore o collegandosi ad un palo della luce in strada. E non parlo di ragazzi persuasi da pubblicità, da mode o da Internet, parlo di un fiore cresciuto su una roccia, dell’esigenza di lasciare la palla di cuoio a casa per ritrovarsi sotto una tenda di gomma, temperatura esterna di trenta gradi, per sfidarsi con una palla virtuale, quasi questo passaggio fosse un istinto, come se facesse parte dell’evoluzione naturale umana. Avevano creato le sale giochi: improvvisate, costruite con legni e teloni di camion sparse tra i vicoli labirintici delle province della capitale della RDC, Kinshasa, un solo gioco a disposizione, televisioni e PlayStation incrostate di terra. Uno scenario che aveva dell’irreale.
Il salto ad Akihabara è stato istintivo, era il bisogno di mettere a confronto due realtà: la tecnologia che trova il suo spazio anche dove sarebbe impensabile e la tecnologia “nella città della tecnologia”, il paese dei manga, dei video giochi e degli otaku.
E dopo aver isolato il gene otaku nei soggetti ripresi mi è stato facile comprenderne il significato. Ho documentato persone di ogni sesso ed età con i loro NinstendoDs tra le mani, persone che pur uscendo dalle loro stanze si rifugiano dalla società faccia contro al muro per non vedere e non farsi vedere.
Erano tenuti in gruppo da una rete wifi e nonostante si sentisse la scomodità che provavano per questo, il bisogno di essere “connessi” era sicuramente più forte. Non so teorizzare il termine otaku, ma ne ho capito l’essenza e da quando mi sono trovato a condividere il loro spazio ho smesso di scrivere questa parola tra virgolette, il concetto si era concretizzato. In un piazzale antistante un centro commerciale arrivavano nello spot wifi alle 9.30 del mattino e se ne andavano 13 ore dopo senza mai muoversi, tutto quello che gli serviva era nel loro zainetto comprese ovviamente le batterie di ricambio per i DS. Per rispondere alla tua domanda, li definirei quindi “fedeli”.
GameScenes: Che cosa hai potuto concludere dalla tua ricerca fotografica relativa alla Cultura dei Videogame?
Sono contento di poterti rispondere che una conclusione non c’è, ho documentato gli antipodi di un approccio al video gioco, la ricerca di un isolamento all’interno di una rete wifi condivisa in una piazza e lo sfidarsi a una partita di calcio seduti così vicini da faticare a manipolare il proprio gamepad. E’ così vasto l’intervallo tra questi due mondi che non posso ancora dire di aver concluso questa ricerca.
GameScenes: Qual è il tuo rapporto personale con i videogame?
Gioco a Pac-Man su iPhone… Per il resto ti posso dire che ho portato come tesi di laurea i mondi virtuali, i MMORPG, e in particolare Second Life senza però mai esserci entrato. E’ una piacevole resistenza forzata che m’impongo.
GameScenes: A quali progetti stai lavorando oggi? Pensi di confrontarti ancora con i videogiochi?
Assolutamente sì, è un fenomeno che mi attrae moltissimo ed essendo in continua evoluzione sarà difficile trovare una conclusione. Ho un conto in sospeso nella Repubblica Democratica del Congo e intendo saldarlo al più presto, non mi sbilancio nel raccontartelo nei particolari ma riguarderà in qualche modo ancora i videogiochi. Ma sono tantissimi i punti di questa cultura che vorrei analizzare e che sento di dover approfondire.
GameScenes: Ti sei laureato all’Accademia di Belle Arti con una tesi intitolata “Mondi Virtuali – Net-Art”: puoi riassumere brevemente la tua ricerca e, soprattutto, le conclusioni a cui sei arrivato?Era da poco comparso Second Life ed era nato un nuovo mondo tutto da conquistare! Si poteva volare, la Coca Cola aveva comprato un’isola e gli artisti cominciavano a lavorare con e all’interno di esso, si inauguravano eventi contemporaneamente dentro e fuori e il confine tra reale e virtuale si era fatto sottilissimo. Mi sembrava davvero un terreno fertile sotto ogni punto di vista e talmente interessante da dover essere portato come tesi conclusiva dei miei studi all’Accademia che mi avevano più volte portato a confrontarmi con il “virtuale”. Per poter parlare di ciò era stato necessario partire dalla net.art, creatrice di una nuova estetica. Tutto ciò mi servì a dimostrare l’impossibilità di distinguere il reale dal virtuale, “ciò che è” da “ciò che non è”, il gioco dalla realtà: tutto può coincidere.
GameScenes: Qual è la funzione e il ruolo sociale ed artistico di un fotografo nell’era di iPhone, Instagram e flickr?
Flickr, Instagram, Facebook e tutto quello che in questo momento immagazzina immagini svolge sicuramente un ruolo antropologico culturale, sono e saranno lo specchio di oggi. Sono grandi album fotografici di una famiglia globale.
L’iPhone e tutto quello ad esso correlato è l’evoluzione dell’Istantanea Polaroid. L’immediatezza dello scatto è accompagnata dall’immediatezza della divulgazione e si ha la possibilità di diventare editore di se stessi. Tutti scattano e in questa società di photosharing il fotografo potrebbe sedersi e stare semplicemente a guardare, classificare, filtrare, e documentare appropriandosi d’immagini preesistenti. E’ per me un territorio vastissimo e concettualmente affascinante.
Intervista di Matteo Bittanti
Collegato: L'arte videoludica di Stefano Spera
Immagini di Giovanni Fredi, "Kinshasa vs. Akihabara" (2010-2011)